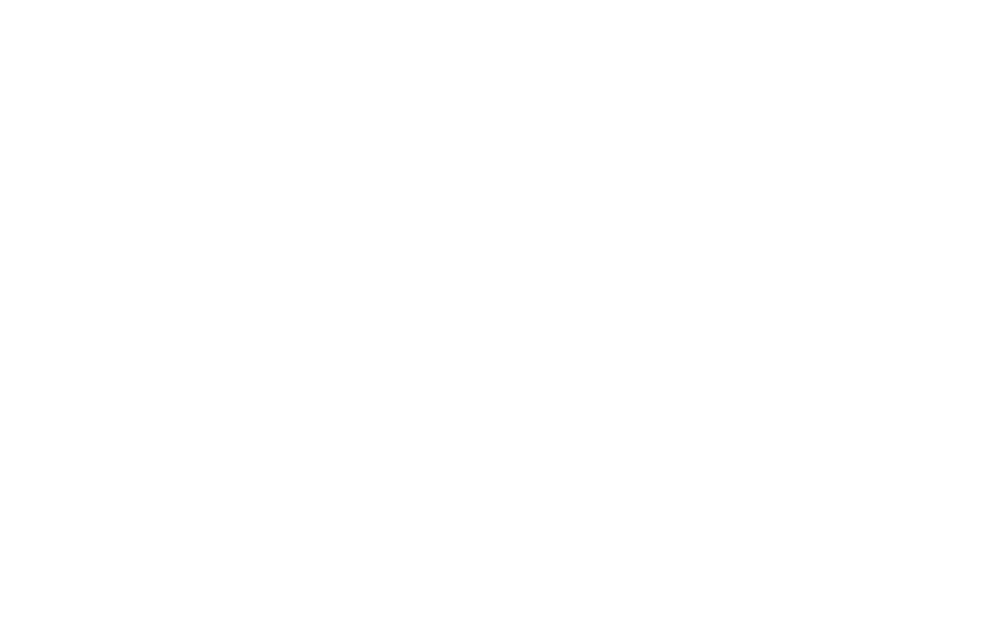A cura di Gaia Bettio, Carla De Rosa e Concetta Sorvillo (Scuola del libro), Sara Bonora (Liceo L. Ariosto di Ferrara), Alessandro Cerra (Liceo L. Da Vinci di Salerno), Arianna Marzo (Istituto G. Salvemini di Alessano), Giulia Mereu (Liceo A. Pacinotti di Cagliari) e Giovanni Ruocco (Istituto A. Pacinotti di Scafati).
Ditke vive in un piccolo paese dell’Ungheria rurale a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta. Ha dodici anni quando viene privata della sua infanzia: il pane perduto, lasciato a lievitare per sempre nella casa di famiglia abbandonata in fretta e furia, segna l’inizio della sua esperienza ad Auschwitz. Nell’odissea senza fine dei campi, le resta solamente la sorella Judit: saranno l’una la forza dell’altra fino alla loro liberazione. Ditke si affaccia su un mondo alieno, quasi ostile, del quale non riesce a riconoscere i tratti. La sensazione di essere estranei persino a sé stessi, la voglia di essere ovunque e in nessun luogo. L’irrequietezza fisica, psicologica, emotiva porta Ditke dapprima in Israele: luogo favoleggiato dalle tradizioni in cui non riesce a trovare l’insperata pace; poi in giro per l’Europa, a seguito di una compagnia di altri esuli come lei. Finalmente l’approdo in Italia, dove Ditke ritrova l’identità e la voce: comincia a scrivere, una necessità costante quasi famelica, un flusso che scioglie il nodo dei ricordi; conosce il compagno di una vita, il poeta Nelo Risi; tramanda la memoria alle nuove generazioni. E comincia a vivere.
La sua produzione letteraria (sia prosa che poesia) è strettamente legata alla testimonianza della Shoah. Cosa l’ha portata adesso, a distanza di tutti questi anni, a scrivere Il pane perduto? E in che rapporto si pone rispetto alle sue opere precedenti?
Dopo sessant’anni mi è sembrato giusto ricominciare a raccontare il mio vissuto, in particolare la mia infanzia e il tempo trascorso in Italia. Gli argomenti che tratto sono purtroppo molto attuali. Ormai faccio testimonianza da oltre sessant’anni, soprattutto nelle scuole, e posso affermare con certezza che già dopo la guerra si è cominciato a mistificare quello che era avvenuto. La sofferenza tocca ancora oggi moltissime persone, i sopravvissuti e soprattutto gli “altri”: i collaboratori, gli alleati della Germania nazista, chi ci ha deportato, gli ungheresi stessi. Raccontare è sempre un gesto attuale, bisogna ricordare e tenere la memoria viva sempre, fino alla fine. Questa non è una storia che riguarda soltanto me, ma tutti, e lo dimostra la frequenza con cui si verificano episodi di violenza, razzismo, discriminazione e persecuzione. Credo che il mondo manchi proprio di amore.
Per questo è necessario raccontare e in tutte le scuole in cui sono andata i giovani mi hanno ascoltata, perché in fondo è sufficiente parlargli: ho incontrato persone splendide, che quasi mi spaventavano perché sembravano fin troppo mature. Come dico sempre: se riesco a cambiare anche solo poche persone non sono sopravvissuta inutilmente. Sono certa comunque di averne cambiate molte di più, perché trovo sempre risposta da parte dei ragazzi. Quando entro in una scuola ho sempre l’animo pesante perché so di dover affrontare temi molto difficili e io stessa soffro raccontando. Quello che è davvero importante, però, è che i più giovani sappiano e tengano gli occhi ben aperti per sé, per il futuro e per il mondo. Primo Levi mi diceva sempre: «Noi facciamo la guardia e raccontiamo, e questo raccontare in qualche misura ci alleggerisce del peso che portiamo dentro, perché non è un vissuto che si può dimenticare né si deve dimenticare».
In un primo momento il titolo Il pane perduto può sembrare oscuro, e infatti si svela lentamente durante la lettura: simboleggia il legame con le origini e con la religione, il punto di svolta nella vita della famiglia, il richiamo a un passato quasi fiabesco, e l’altruismo nei momenti più bui. Questo valore proviene dalla madre o è una sorta di rassegnazione vicina all’indulgenza?
Quando all’alba i fascisti ungheresi buttarono giù la nostra povera porta per trascinarci via, la prima cosa a cui pensò mia mamma fu al pane che stava lievitando. La farina ce l’aveva regalata la nostra vicina in occasione della Pasqua ebraica, durante la quale non si mangia pane per otto giorni. La tradizione risale alla fuga dall’Egitto, quando non c’era stato tempo di far lievitare il pane. Il gesto della vicina dimostra che non è mai tutto nero nella vita, neanche nei momenti più bui: è per questo che nel libro parlo dei «cinque punti di luce». Mia madre, che diceva sempre che «quando c’è pane c’è tutto», era disperata per quelle cinque pagnotte, che per noi erano la vita. Quando ci hanno buttati fuori dalla nostra casa lei ha fatto confluire inconsciamente il suo dolore, e il presentimento di qualcosa di mostruoso, su quel pane. Mentre piangeva continuava a ripetere che il pane era perduto. Questo grido ci ha accompagnato fino al ghetto − dove ho visto per la prima volta un tedesco − e non mi feriva quanto le bestemmie dei miei connazionali ungheresi. Se ogni loro parola era uno sparo, una frecciata, la lingua tedesca invece non poteva toccarmi perché non la capivo e riuscivo solo a intuire il significato di alcune frasi − perché conosco un po’ di yiddish che assomiglia a un “brutto tedesco”. L’ungherese invece era una ferita terribile.
C’è da dire che non tutti nel nostro quartiere erano fascisti. Un contadino benestante riuscì inspiegabilmente a superare sia le guardie ungheresi che quelle tedesche, portando dei viveri con sé dentro il ghetto. Forse aveva dato qualcosa anche a loro, forse si è trattato di corruzione, in ogni caso era un gesto “impossibile” in quella situazione. Mia mamma piangeva di felicità. Lo voglio raccontare perché è necessario ricordare quei frammenti di luce scrutati nel buio più pesto grazie ai quali abbiamo pensato che valesse la pena difendere la nostra vita.
A proposito della lingua, nel Pane perduto essa ha una connotazione simbolica: la protagonista non conosce l’ebraico come la madre e la sorella e sembra riacquisire la propria voce solo una volta arrivata in Italia. Alla fine del libro lei sostiene che «sono necessarie parole nuove, un nuovo linguaggio anche per raccontare Auschwitz». Qual è dunque il ruolo della lingua?
La lingua, quella italiana, per me è identità insieme a questo paese. Non voglio dire che è patria perché non mi piace questa parola, visto che in nome della patria, così come nel nome di Dio, sono state commessi atti orribili. La lingua è una sorta di Muraglia Cinese: mi difende dai ricordi molto dolorosi, come quello della lingua ungherese, la mia lingua natia. Al contrario l’italiano mi ha dato un’identità, la possibilità di esprimermi, ma anche una casa e un marito. Si può dire che tutto quello che potevo desiderare l’ho ricevuto dall’Italia. Ma penso di aver dato anche io molto a lei in questi sessant’anni, grazie alla mia testimonianza nelle scuole.
Una volta mentre ero in una scuola mi sono accorta che alcuni studenti ascoltavano musica invece di ascoltare me. Così ho detto loro che chi non era interessato poteva andare via: sono usciti in cinque, ma per me contavano solo gli altri quattrocentonovantacinque rimasti. In queste occasioni molti ragazzi si commuovono, e io stessa piango. Per i primi vent’anni, ad esempio, ogni volta che arrivavo al racconto della separazione da mia mamma crollavo: quella parte non sono mai riuscita a descriverla fino in fondo, dentro di me qualcosa si rompeva. È successo anche tre giorni fa. Forse però è meglio saper piangere piuttosto che essere di pietra, finché riusciamo a provare qualcosa va tutto bene. Il guaio è quando non siamo più in grado di farlo.
Nel libro parla spesso della sua passione per la scrittura e della difficoltà di poterla coltivare in mancanza di quaderni. Nonostante sua sorella la inviti a lasciare da parte il suo sogno, lei ha continuato a scrivere. Come si è evoluto questo rapporto con le parole nel corso del tempo? Com’è stato dare vita a un libro così denso di memoria e affidarlo a un editor?
Quando siamo tornate dal campo di concentramento mia sorella Adele è stata per molto tempo un grande appoggio. «Non c’era ascolto», come diceva Primo Levi, perché la guerra era ancora troppo viva e dolorosa per tutti. Ma la loro sofferenza era diversa dalla nostra che era un unicum nella storia del Novecento, e non si poteva paragonare a nient’altro. La mancanza di predisposizione all’ascolto era per molti una forma di difesa e non di cattiveria, però noi avevamo una tale voglia di raccontare. Mi sentivo “gonfia” di parole e sopportare non mi era più possibile. Così ho preso una matita e un quaderno – uno scolastico, perché non avevo nient’altro – e ho cominciato a scrivere in ungherese il mio primo libro, Chi ti ama così, uscito nel 1959.
Poco dopo il mio ritorno ho dovuto lasciare nuovamente l’Ungheria perché non c’era possibilità di cominciare una nuova vita, sia nel mio villaggio che nel resto del paese. Non sapevo dove andare, come vivere e con chi: avevo perso i miei genitori, mio fratello, la nostra casa era stata distrutta. Ho raggiunto una delle mie sorelle in Cecoslovacchia, e lì mi hanno detto di disfarmi subito di tutti i testi in ungherese perché se li avessero trovati ci avrebbero imprigionati. Odiavano il nostro popolo. Ho buttato via le pagine già scritte ma non l’intero libro: avevo messo nero su bianco solo una parte di esso, il resto era al sicuro nella mia mente. Infine, quando sono arrivata in Italia, ho imparato una nuova lingua e nel 1946 ho ricominciato a scrivere lo stesso libro: non mi era più possibile sopportare quel veleno che era rimasto dentro il mio corpo. Avevo bisogno di dire, gridare. Sapevo che la carta avrebbe sopportato tutto e se gli esseri umani non avevano orecchie per ascoltare – e non volevano farlo − allora avrei scritto. Così seduta su uno sgabello, appoggiata a un baule – l’unica cosa che mi restava – ho dato vita a Chi ti ama così. Un libro bello, tanto che all’epoca lo scrittore Romano Bilenchi e il poeta Mario Luzi fecero una scommessa: quest’ultimo era convinto che avrei continuato a scrivere, mentre l’altro pensava il contrario. Ha vinto Mario Luzi perché da quel momento non mi sono mai più fermata.
Fin da bambina, quando la mamma mi diceva di dire le preghiere a letto, io mormoravo una poesia. Non avevo più osato scriverne dopo l’infanzia, anche se sono sempre stata convinta che fosse il massimo dell’espressione letteraria. Il mio primo componimento si chiamava L’uguaglianza padre. Il titolo faceva riferimento alla medesima condizione di impotenza cui tutti gli uomini sono condannati di fronte alla guerra. Era il primo membro della famiglia di cui scrivevo, poi sono passata a mia mamma e mio fratello, e lentamente è nato Il tatuaggio. Adesso l’Università di Macerata ha raggruppato i miei primi tre libri in un unico volume dal titolo Versi vissuti. A breve pubblicherò un quarto libro di poesia per La Nave di Teseo che si chiamerà Tempi.
Dunque per lei la scrittura è un flusso istintivo? Oppure ci sono delle costruzioni di struttura alla base? Considerata la tematica così intensa, come vive l’emozione del produrre un’opera simile?
Ho sempre detto che rimango incinta di un libro, come se partorissi ogni volta che scrivo, perché i libri sono come figli che maturano dentro di me. A volte basta un titolo come Il pane perduto e comincio a scrivere. È un flusso ed è continuo: non mi fermo mai fino a quando non arrivo alla fine di una storia. La cosa incredibile è che non decido mai come continuerà e quale sarà la lunghezza. Sono una scrittrice istintiva e carnale, mai mentale. Come diceva uno scrittore inglese alla fine il libro si scrive da sé, quindi mi basta un titolo o un pensiero per cominciare. Per la poesia vale la stessa cosa. C’è qualcosa di miracoloso in tutto questo.
Questo è un libro molto intenso: in centoventi pagine è riuscita a racchiudere tutta la sua esistenza. Se riflette sul passato, e più in generale su tutto ciò che ha vissuto, cosa pensa dell’essere umano di oggi? Crede che la sua natura possa cambiare?
È difficile dire cosa penso del genere umano, ma di certo non ripongo molta fiducia in esso. Credo che l’uomo non cambierà mai la sua natura: non lo ha fatto né ieri né oggi, e non lo farà domani. In qualche maniera siamo tutti ottusi, autopunitivi, e ci sentiamo sempre responsabili di qualcosa, come se esistesse una colpa ancestrale a dominarci. Altrimenti è impossibile spiegare perché non impariamo mai nulla dal passato. Basti pensare che ingegneri, architetti, scienziati, medici e tecnici si sono seduti a tavolino per calcolare come annientare migliaia di persone e sfruttare tutto quello che potevano del corpo umano: è stato fatto da esseri intelligentissimi, scienziati, non analfabeti. Mi domando allora a cosa serva l’intelligenza, se l’uomo capace crede di avere il diritto di decidere del destino di un popolo. In molti, come ad esempio l’architetto di Hitler, Speer − su cui mio marito girò un documentario − si sono limitati a dire di aver solo eseguito gli ordini. Nei miei libri e, soprattutto in Lettera alla madre, ho dichiarato di preferire un padre vittima a un padre assassino che esegue comandi di altri.
La Seconda guerra mondiale è stata una mostruosità, un massacro folle, e nonostante questo in tanti continuano ad armarsi nel nome della pace. Allora cosa può far cambiare l’uomo? Di certo non la fede, perché da sempre si combattono molte guerre in nome di Dio. Come dicevo a Papa Francesco, tutti possiamo fare una piccola parte di bene nel mare del male. Prima di ogni cosa è fondamentale rispettare il prossimo, chiunque egli sia, di qualunque colore sia la sua pelle e a qualunque religione appartenga. Basta davvero poco, un minimo di tolleranza, di empatia e di vicinanza. In questo senso il futuro dipende soprattutto dai giovani, che hanno la possibilità di agire e protestare, ma anche avvicinare e amare il prossimo. È necessario, però, che gli adolescenti escano dal loro stato di isolamento: devono essere rieducati al dialogo e al confronto tra di loro, ma anche con i genitori e con i nonni. Gli anziani sono figure fondamentali e convivere con loro significa conoscere il loro vissuto. Non bisogna allontanare, ma avvicinare e curare. Io ho curato mio marito per undici anni. Ogni giorno i medici mi dicevano che sarebbe morto, e invece non era così, perché l’amore è la medicina migliore che esista.
Primo Levi in Se questo è un uomo scrive che per la sua sopravvivenza è stata essenziale l’amicizia con Alberto, il compagno con cui ha condiviso gran parte della prigionia, mentre per lei Edith è stata vitale la presenza di sua sorella maggiore. Questo dimostra che anche all’interno di un’umanità così degradata, si possono trovare rari esempi di altruismo e generosità, quelli che lei chiama i cinque momenti di luce. Vuole parlarcene?
Sì, vorrei ricordare i primi quattro. Il primo è stato all’arrivo ad Auschwitz: un soldato tedesco, uno di quelli che ci selezionavano come fossimo bestie, mentre ero aggrappata al corpo di mia madre mi ha sussurrato di andare a destra perché a sinistra c’era la morte immediata. Quell’uomo ha massacrato mia madre, ma mi ha buttata dall’altra parte convinto che, pur facendo i lavori forzati, sarei sopravvissuta. Sono certa che qualcosa deve essersi smosso in lui.
Il secondo riguarda un cuoco a Dachau che mi chiese quale fosse il mio nome. Questo episodio l’ho ricordato anche durante un colloquio con Papa Francesco. Sentirsi chiedere come ti chiami dopo che sei stata solo un numero è una cosa inimmaginabile. Significa scoprire di essere ancora un essere umano: chi non è stato in un campo di concentramento, anzi di annientamento, non può comprendere fino in fondo. Il cuoco mi disse di avere una bambina come me, tirò fuori un pettinino dal suo taschino del camice e me lo regalò per farmi pettinare i capelli rasati e corti. È stata una manna dal cielo che mi ha fatto sentire felice e viva. Non riesco a spiegare cosa abbia significato per me in quel momento essere e non sentirmi un numero, non più 11152 ma Edith.
Il terzo riguarda un soldato di Kaufering, uno dei cento sotto-campi di Dachau (mentre in tutta la Germania e l’Europa esistevano milleseicentotrentacinque campi di concentramento). Dachau era soltanto a diciassette chilometri da Monaco di Baviera, ma io mi sentivo fuori dal mondo civile. Lì un soldato mi diede una gavetta da lavare scagliandomela addosso, e io ispezionai il bordo per capire se fosse rimasta della marmellata da leccare. Ho visto che ne aveva lasciata un po’. Papa Francesco mi ha chiesto che significato ha avuto quel momento, e io ho risposto semplicemente: la vita, la luce. Un altro soldato mi regalò un guanto bucato, e anche quel gesto ha significato tanto. Può darsi che i suoi guanti fossero bucati perché la guerra stava già finendo, e anche i tedeschi si erano impoveriti.
Dopo Auschwitz, in un campo di transito vicino Monaco, ho dato da mangiare a ex-soldati nazisti; allo stesso modo, ho riportato a casa cinque fascisti austriaci. Questo perché bisognava ricominciare dalla pace e non dalla vendetta e dall’odio. Bisogna avvicinarsi al nemico, perché forse non sarà più tale, non sarà più fascista.
Un altro momento di luce è stato a Bergen-Belsen, dove ho vissuto uno dei momenti peggiori, troppo triste per essere raccontato. Mia sorella maggiore aveva attaccato un soldato che mi aveva aggredita. Io ero seduta nella neve, insanguinata, e avevo gettato a terra dei giubbotti che non riuscivo più a portare. Lui ha messo via la pistola, mi ha allungato la mano e mi ha aiutato ad alzarmi ma con un atteggiamento tipicamente razzista e nazista e me ne ha dette di tutti i colori: che sì ero una «sporca ebrea», ma che se riuscivo a mettere le sue luride mani su un tedesco allora meritavo di sopravvivere. Non mi ha ammazzata e mi ha guidata sulla strada del ritorno, nella neve, per otto chilometri, mentre camminavo con gli zoccoli. Mi ha aiutato ogni volta che ero colta dalla diarrea, e ad alzarmi quando cadevo. Continuavo a chiedergli del pane, come se parlassi con mia madre − «per piacere pane, brot bitte, bitte» −, pane che non mi ha dato, perché appena siamo arrivati al campo è sparito. Mi ha salvato però. Un momento di luce, anche se fioca. E finché c’è luce, c’è vita.
Revisione a cura di Manuela Altruda